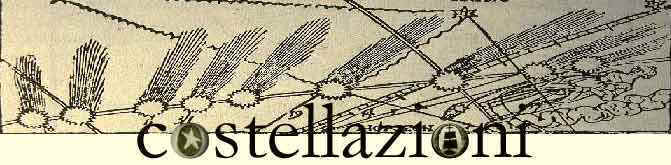Insomma
il protagonista maschile vorrebbe raggiungere un certo dominio di sé
ma l’amata, vera forza naturale distruttiva, gli è di ostacolo
impedendogli di realizzare la ‘vita nuova’ a cui egli aspira. Solo
la morte, e qui il vate non è nemmeno un po’ originale dopo gli
eccessi romantici (si pensi alla ‘Belle dame sans merci’) e
decadenti anche in pittura (‘Lady Lilith’ di Dante Gabriel
Rossetti) lo libererà dal giogo sensuale di Ippolita. Lei è come
‘un male sacro, il morbo astrale’ tutti ingredienti necessari per
giustificare l’ingenuità bonaria del povero Adamo di turno. Queste
donne rovinauomini non sono particolarmente belle, non bellezze
canoniche, né madonne naturalmente. Il loro fascino sta nella torbida
attrazione che esercitano sui loro amanti. Del resto, l’idea, quella
geniale davvero, viene dalla ‘dark lady’ di Shakespeare che,
esasperato dalle descrizioni angelicate dell’amor cortese dove
bellezza è coniugata a bontà, si libera dello stereotipo e, con
tocco sapiente, stupisce
il lettore presentando nel sonetto CXXX una donna dai
‘capelli di fil di ferro neri’, ‘il seno bruno’ e
l’alito sgradevolmente cattivo che ’nel fiato di lei aulisce.’
A
riparare tanti sbreghi di immaginari febbricitanti e deliranti qualche
voce femminile verso fine ‘800, con profetica lucidità, tenta di
togliere alla donna questa etichetta di ‘fausse couche’. Quello
che affascina è la non asprezza del tono e la non condanna fuori
luogo dell’altro sesso. L’esule russa Anna Kuliscioff (nonostante
il cognome ammiccante non aspira a fare la danza dei sette veli) se ne
esce nel 1890 in una conferenza presso il Circolo Filologico Milanese
(riportata poi su ‘Critica Sociale’ rivista che Turati, suo
compagno, dirige in quegli anni) parlando di giustizia sociale, di
eguaglianza civile tra gli esseri umani. Non odio, non rivalsa ma
aspirazione ad ottenere cooperazione cosciente
degli uomini sensibili, emancipati dalla consuetudine e dai
pregiudizi, disposti a riconoscere che anche le donne possono essere
degne a sé senza essere per forza relegate nei
soliti ruoli di angeli senza ombra o peccatrici mai redente. Un
far posto insomma alla capacità di astrazione e creatività della
donna e non solo alla sua innata intuizione e propensione ai
sentimenti.
Anche
questi pensieri servono forse a far capire come la letteratura di fine
secolo cercasse di difendersi dalle diverse anime che le donne,
allora, cominciavano a svelare. Tante Salomé per esorcizzare
l’anelito di libertà che fibrilla da sempre nella parte più
delicata di ogni creatura : maschio o femmina che sia.