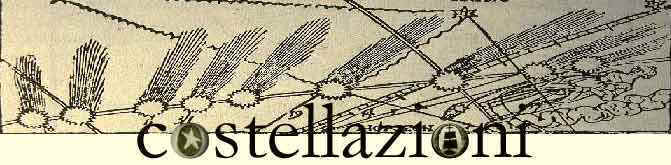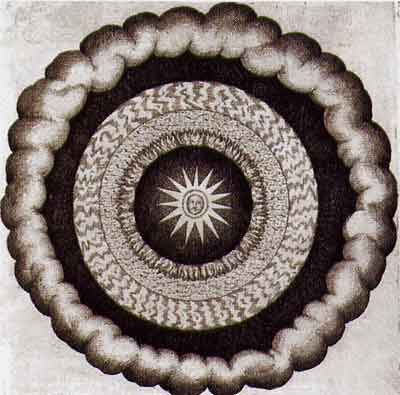Too late… too late.
Otto
metri quadrati, nessun dialogo solo musica trinciata come ragnatela;
una bambina bacia le croci e suona una spinetta scordata, il vento
sibila trapassando le pareti; i colori sono urlati, aggressivi, il
film è ossessionato, ossessionate. Montaggio schizoide: quattromila
inquadrature per un’ora esatta di riprese, immagini talvolta quasi
impercettibili, le spuntinature corrette fotogramma per fotogramma
con le aniline e le lenti di ingrandimento: un lavoro “da
impazzire. E forse impazzimmo davvero. Dicono che Godard si
rifiutasse di credere che tutti i mie film provenissero dal 16 mm.
Non si capacitava”.
Il
Don Giovanni di Carmelo Bene, il più folle degli
“hommage-delitto” siano mai stato perpetrati su
e a Barbey d’Aurevilly, l’Unico, el Desdichado,
l’insuperato Maestro di fiammeggianti nefandezze, peccaminose
santità (ma lo sapevate che soffocato da una crisi finanziaria,
decise di mettersi nel commercio di oggetti liturgici? Per di più
nei pressi di San Sulpice, la chiesa diabolica di Là-bas, il
romanzo satanista di Huysmans. Praticamente come in Magrelli “e
voglio un giorno farmi reliquia di me stesso”).
Questa
lettura del Don Giovanni, “film di un cervello schizzato, opera di
un poeta pazzo alla Nerval”, è una summa del Mondo e della sua
Rappresentazione, bulino che incide a sangue il
Dongiovannismo e tutto il resto.
Alla
prima nessuno nessuno capì nulla. Presentato a Cannes nel 1970, e
poi eccezionalmente anche in agosto, a Venezia, nei cinema si
assistette a furibonde proteste: poltrone divelte, sedili
incendiati, schermi distrutti…un fiasco epocale, da montarsi
irreparabilmente la testa.
Solo
due vecchine -guanti ricamati e veletta- sulla Promenade di Cannes
azzardarono: “Maestro, c’è qualcosa di Barbey nel suo splendido
film?”. Le uniche a riconoscere nella claustrofobia delle immagini
l’ordito del “diabolica” più soffocante, Il Più bell’amore
di Don Giovanni.
Una
bambina assiste all’incontro della mamma col suo amante; ne rimane
sconvolta, si getta ai piedi del crocifisso, deve accorre persino il
confessore, non c’è verso di tranquillizzarla. Solo alla fine,
sciolta la tensione nelle lacrime, confesserà: ”Mamma, è stato
una sera. Lui era nella grande poltrona vicina al caminetto, di
fronte al divano. Vi rimase a lungo e quando si alzò io ebbi la
disgrazia di andarmi subito a sedere nella poltrona lasciata vuota.
Oh! Mamma!... fu come cadere nel fuoco: volevo alzarmi, non
potevo… il cuore mancò! E sentii che… ecco: qui mamma!...
sentii quello che avevo… era un figlio!”
La
scena iniziale è concepita sull’onda del catalogo mozartiano, con
l’intenzione di demolirne il senso: Don Giovanni è orami un
vecchio, “uomo rovinato dalle bugie”, il catalogo è soltanto un
ventaglio di falsità. I costumi - citazioni da Ingres, Cranach,
Rembrandt - coprono solo il “davanti”, la “facciata” della
donna; una sola attrice interpreta tutte e dodici le amanti; la
stessa donna, palesemente la stessa, ora truccata da grassetta, ora
da piccina… La sua schiena è nuda,
anche il Re ormai lo è, tutti lo sanno:
la falsità della seduzione è finalmente palpabile “a
pelle”.
L’inganno
del catalogo può ora solo sbriciolarsi nello specchio infranto,
“frammenti di volto frammenti di riso”.